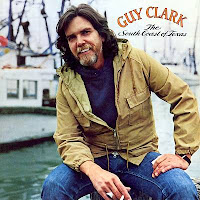Fallen Angels
(Columbia Records, 2016)
★★
All'inizio, aveva parlato di "disco gospel", lo zio Bob. Poi di un ulteriore selezione di omaggi a Sinatra. Infine, era tornato sui propri passi definendolo uno standard album come ne ha già fatti. In realtà, delle dodici canzoni presenti nella sua "opus in studio" n° 37, ben undici hanno già goduto di una reinterpretazione da parte di The Voice. Non si tratta di una raccolta di scarti di Shadows In The Night (2015), badate bene, ma di canzoni scelte, arrangiate e registrate ex novo con la band del Never Ending Tour. Nulla che il più originale e geniale autore della canzone moderna non abbia già fatto nel corso della sua carriera (chi ricorda i particolari Good As I Been To You e World Gone Wrong, usciti fra 1991 e 1993?), ma allora perchè, a distanza di poco più di un anno dal precedente album, tutti scrivono e si dividono su Fallen Angels?
I più "faciloni", quelli che ormai taglian corto perchè scrivere sulle nuove paturnie dei Radiohead ha la priorità assoluta, affermano che non gli sta bene che "il loro amato" Dylan pubblichi due dischi di fila contenenti soltanto covers. Costoro potranno sentire proprio e amare Dylan quanto vogliono, ma dimostrano di non aver ancora compreso un tratto fondamentale di questo artista che è però ben riassunto in un vecchio adagio: "Mick Jagger vuol essere adorato dal suo pubblico, Bruce Springsteen vuol essere amato dal suo pubblico, a Bob Dylan del suo pubblico non gliene frega un cazzo".
Poi ci sono i dylaniani, ovvero gli esatti opposti, gli antipatici antipodi (per citare un grande poeta della canzone di casa nostra), quelli che hanno comprato The Bootleg Vol.12 nell'edizione da 18 cd contenenti "every single note" che Dylan ha registrato fra il 1965 e il 1966 (colpi di tosse, errori e bestemmie compresi) e che per Fallen Angels, se ce ne fosse stato bisogno, avrebbero fatto anche la coda nella notte fra il 19 e il 20 maggio. Ma Fallen Angels non è un iPhone e Bob Dylan- per quanto Steve Jobs lo abbia amato, emulato e invidiato e abbia attinto dalla fonte del suo canzoniere -non è la Apple Computer.
Infine, ci sono i dylanisti, la schiera nella quale anche io sento di dovermi inserire. In realtà, fino ad alcuni anni fa, anche io mi definivo un dylaniano, ma poi, una sera, leggendo un bel libricino che si intitola Canzoni d'amore e misantropia (lo ha scritto Alessandro Carrera ed è edito da Feltrinelli), ho capito di essere molto più dylanista. E i dylanisti non sono i dylaniani (al massimo, sono dylaniati), non rincorrono le nuove uscite del loro beniamino ovunque si trovino e qualunque forma assumano, non ridono in faccia al destino comprando sempre e comunque i biglietti migliori per gli spettacoli o magnifici o deflagranti del Never Ending Tour, non dicono che un nuovo album di Bob Dylan è un capolavoro a prescindere, anche solo per il fatto che Dylan è ancora qua a tenere concerti, pubblicare dischi e far parlare di sè in vari frangenti. Il dylanista sottoscritto, ad esempio, non compra un nuovo album di Dylan originale da una decina di anni, ma sa benissimo che Together Trhough Life poteva meritare un recupero in economica e che Tempest è stato l'ennesimo capolavoro. Si limita all'acquisto dei Bootleg che ancora ritiene interessanti (ho saltato il 9, ma ho preso subito i volumi 10, 11 e 12) e pure fra quelli non ricerca, necessariamente, l'edizione più prestigiosa (nel caso del 12 ho optato per la pregevole cernita spalmata su due dischetti). Ovviamente, storce il naso di fronte a questi album contenenti standard, anche se, ascoltando Melancholy Mood, si meraviglia di come Dylan possa ancora stupire cambiando- a 75 anni! -modo di cantare. Capisce che, come già accaduto anni fa col disco di Natale, siamo di fronte a materiali che un europeo del Ventunesimo Secolo fatica enormemente a comprendere. Le canzoni di Fallen Angels- come quelle di Shadows In The Night -arrivano dall'infanzia e dalla giovinezza di Robert Zinneman, un ragazzetto di Duluth, Minnesota: sono le stesse che milioni di bambini americani senza la televisione ascoltavano giorno e sera su stazioni radio dagli acronimi complicatissimi. Canti gospel, 45 giri hillbilly, i primi singoli della Sun Records, i musicisti blues del Delta del Mississippi, Frank Sinatra e le grandi orchestre swing della East Coast, tutta musica che Bob Dylan ha amato da prima di conoscere i canti di protesta e il folk e di rincorrere, saltando da un treno all'altro, Woodie Guthrie, e dunque, in definitiva, da prima di essere Bob Dylan.
Resta il fatto che a me il risultato non piace, e non perchè non sia ossessionato da Dylan (lo sono eccome e me ne vanto!), ma perchè avverto un'incompatibilità di fondo con l'essenza di questi pezzi. Come i dylaniani più veri e sanguigni, so che il Dylan di oggi non è meno grande di quello di ieri. La sua musica, i suoi album, le sue canzoni e la sua voce hanno reso migliore la mia esistenza, e non sono il solo a cui può essere capitato tutto questo. In virtù di ciò, lo ringrazio per tutto, anche per questi dischi di covers che a me non convincono affatto ma al cui fascino non risulto comunque immune. Dischi anticommerciali, fuori dal tempo, lontani dai diktat imperanti del gusto e dalle mode più passeggere. Dischi che vanno oltre tutto, perfino oltre quella televisione dove ormai la caccia ai talenti è incessante e dove ci si illude di poter trovare i Bob Dylan di domani. La stessa televisione in cui, la sera del 12 maggio scorso, Raffaella Carrà ha sostenuto che Dylan fosse morto 35 anni fa. Anche lei sedeva sulla poltrona di un talent (la poltrona di giudice, per giunta) e dunque che dire? I talent passano, Bob Dylan resta.
I più "faciloni", quelli che ormai taglian corto perchè scrivere sulle nuove paturnie dei Radiohead ha la priorità assoluta, affermano che non gli sta bene che "il loro amato" Dylan pubblichi due dischi di fila contenenti soltanto covers. Costoro potranno sentire proprio e amare Dylan quanto vogliono, ma dimostrano di non aver ancora compreso un tratto fondamentale di questo artista che è però ben riassunto in un vecchio adagio: "Mick Jagger vuol essere adorato dal suo pubblico, Bruce Springsteen vuol essere amato dal suo pubblico, a Bob Dylan del suo pubblico non gliene frega un cazzo".
Poi ci sono i dylaniani, ovvero gli esatti opposti, gli antipatici antipodi (per citare un grande poeta della canzone di casa nostra), quelli che hanno comprato The Bootleg Vol.12 nell'edizione da 18 cd contenenti "every single note" che Dylan ha registrato fra il 1965 e il 1966 (colpi di tosse, errori e bestemmie compresi) e che per Fallen Angels, se ce ne fosse stato bisogno, avrebbero fatto anche la coda nella notte fra il 19 e il 20 maggio. Ma Fallen Angels non è un iPhone e Bob Dylan- per quanto Steve Jobs lo abbia amato, emulato e invidiato e abbia attinto dalla fonte del suo canzoniere -non è la Apple Computer.
Infine, ci sono i dylanisti, la schiera nella quale anche io sento di dovermi inserire. In realtà, fino ad alcuni anni fa, anche io mi definivo un dylaniano, ma poi, una sera, leggendo un bel libricino che si intitola Canzoni d'amore e misantropia (lo ha scritto Alessandro Carrera ed è edito da Feltrinelli), ho capito di essere molto più dylanista. E i dylanisti non sono i dylaniani (al massimo, sono dylaniati), non rincorrono le nuove uscite del loro beniamino ovunque si trovino e qualunque forma assumano, non ridono in faccia al destino comprando sempre e comunque i biglietti migliori per gli spettacoli o magnifici o deflagranti del Never Ending Tour, non dicono che un nuovo album di Bob Dylan è un capolavoro a prescindere, anche solo per il fatto che Dylan è ancora qua a tenere concerti, pubblicare dischi e far parlare di sè in vari frangenti. Il dylanista sottoscritto, ad esempio, non compra un nuovo album di Dylan originale da una decina di anni, ma sa benissimo che Together Trhough Life poteva meritare un recupero in economica e che Tempest è stato l'ennesimo capolavoro. Si limita all'acquisto dei Bootleg che ancora ritiene interessanti (ho saltato il 9, ma ho preso subito i volumi 10, 11 e 12) e pure fra quelli non ricerca, necessariamente, l'edizione più prestigiosa (nel caso del 12 ho optato per la pregevole cernita spalmata su due dischetti). Ovviamente, storce il naso di fronte a questi album contenenti standard, anche se, ascoltando Melancholy Mood, si meraviglia di come Dylan possa ancora stupire cambiando- a 75 anni! -modo di cantare. Capisce che, come già accaduto anni fa col disco di Natale, siamo di fronte a materiali che un europeo del Ventunesimo Secolo fatica enormemente a comprendere. Le canzoni di Fallen Angels- come quelle di Shadows In The Night -arrivano dall'infanzia e dalla giovinezza di Robert Zinneman, un ragazzetto di Duluth, Minnesota: sono le stesse che milioni di bambini americani senza la televisione ascoltavano giorno e sera su stazioni radio dagli acronimi complicatissimi. Canti gospel, 45 giri hillbilly, i primi singoli della Sun Records, i musicisti blues del Delta del Mississippi, Frank Sinatra e le grandi orchestre swing della East Coast, tutta musica che Bob Dylan ha amato da prima di conoscere i canti di protesta e il folk e di rincorrere, saltando da un treno all'altro, Woodie Guthrie, e dunque, in definitiva, da prima di essere Bob Dylan.
Resta il fatto che a me il risultato non piace, e non perchè non sia ossessionato da Dylan (lo sono eccome e me ne vanto!), ma perchè avverto un'incompatibilità di fondo con l'essenza di questi pezzi. Come i dylaniani più veri e sanguigni, so che il Dylan di oggi non è meno grande di quello di ieri. La sua musica, i suoi album, le sue canzoni e la sua voce hanno reso migliore la mia esistenza, e non sono il solo a cui può essere capitato tutto questo. In virtù di ciò, lo ringrazio per tutto, anche per questi dischi di covers che a me non convincono affatto ma al cui fascino non risulto comunque immune. Dischi anticommerciali, fuori dal tempo, lontani dai diktat imperanti del gusto e dalle mode più passeggere. Dischi che vanno oltre tutto, perfino oltre quella televisione dove ormai la caccia ai talenti è incessante e dove ci si illude di poter trovare i Bob Dylan di domani. La stessa televisione in cui, la sera del 12 maggio scorso, Raffaella Carrà ha sostenuto che Dylan fosse morto 35 anni fa. Anche lei sedeva sulla poltrona di un talent (la poltrona di giudice, per giunta) e dunque che dire? I talent passano, Bob Dylan resta.